“ALIAS, incontri sulla traduzione”: nasce a Torino il nuovo progetto di Scuola del libro e Fondazione Circolo dei lettori
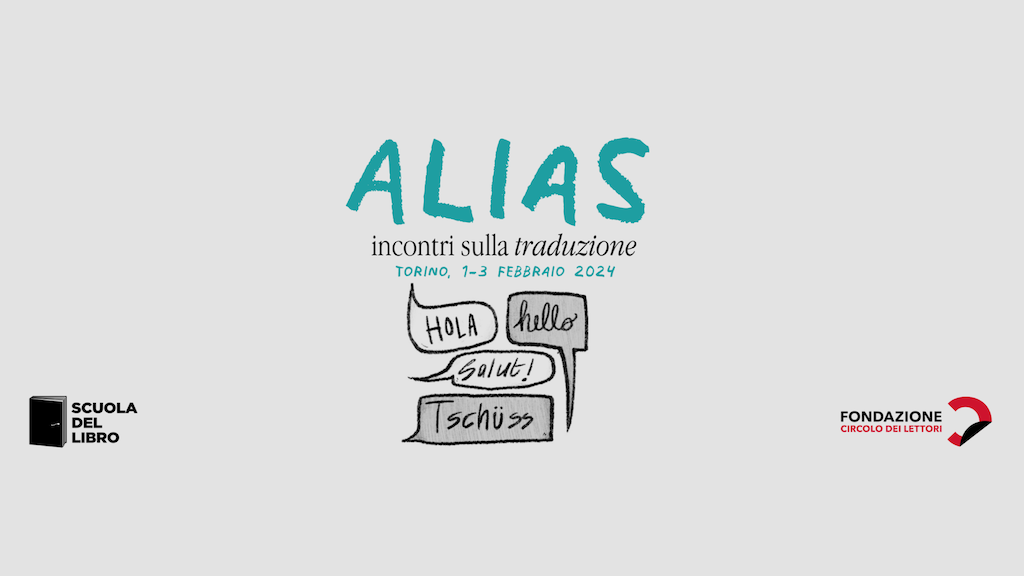
TORINO\ aise\ - “ALIAS. Incontri sulla traduzione” è la prima edizione di un simposio sul tradurre, su chi traduce e chi sogna di farlo promosso e organizzato da Fondazione Circolo dei lettori e Scuola del libro di Torino.
A febbraio, tra giovedì 1 e sabato 3, al Circolo dei lettori si alternano incontri dedicati alla teoria e alla pratica di uno dei più affascinanti mestieri legati al mondo del libro.
“Tradurre non è tradire, è il contrario: far dialogare fra loro lingue, parole, voci di autrici e autori è il principio stesso di ogni arte, non soltanto della letteratura. Perché”, osserva Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori, “la cultura è essa stessa traduzione, messaggio che passa fra chi scrive e chi legge. Ancora una volta, George Steiner ci illumina sull’evidenza che “capire” significa sempre “decifrare”, anche quando la comunicazione avviene all’interno della stessa lingua. Tradurre è anche avere nelle mani, nella testa e nel cuore un mestiere bellissimo che è un confronto quotidiano, intenso e appassionante, in cui ogni giorno le lingue regalano e si regalano qualcosa di nuovo”.
“Le nostre letture sono spesso mediate dal lavoro invisibile di chi, dietro le quinte di un testo, ha sapientemente (ri)costruito scenografia, dialoghi, costumi, luci di quello spettacolo favoloso che è l’opera letteraria, che sembra svolgersi sotto i nostri occhi come fosse nato nella lingua che conosciamo”, dichiara Marco Cassini della Scuola del libro. “Le traduzioni ci portano in mondi e tempi che ci diventano familiari anche se concepiti con altri segni, in altre latitudini. ALIAS racconta tutto questo; è un assaggio di percorsi che qui possono prendere l’avvio. È dedicato a chi i libri in traduzione li legge e desidera indagare quella metamorfosi e a chi quel mestiere alchemico vorrebbe farlo suo”.
Alias inaugura al Circolo dei lettori con l’attrice Valentina Lodovini che legge Margaret Atwood, aprendo le porte di questo universo da esplorare in cinque lezioni tenute da chi ha prestato la penna a classici della letteratura di ieri e di oggi. Oltre le lezioni, tre traduttrici che hanno lavorato a libri di premi Nobel si siedono a una tavola rotonda per confrontarsi sulla sfida di vedersela con i grandi maestri. Tra le traduttrici e i traduttori protagonisti di Alias intervengono: Federica Aceto, Maurizia Balmelli, Margherita Carbonaro, Gaja Cenciarelli, Marco Federici Solari, Lorenzo Flabbi, Gine Maneri, Vittoria Martinetto, Fabio Pedone e Anna Ruchat.
IL PROGRAMMA DI ALIAS
Si parte giovedì 1 febbraio alle 19 con “Consigli per sopravvivere in natura”. Valentina Lodovini legge Margaret Atwood, introdotta da Gaja Cenciarelli.
Da sempre Margaret Atwood trasfigura narrativamente i grandi temi che animano i nostri giorni, dalla incombente catastrofe climatica alla questione femminile; in questo testo, pubblicato in Italia da Racconti edizioni, l’autrice tratteggia un prontuario per sopravvivere sì in natura, ma soprattutto alla nostra natura, quella di esseri umani. La lettura di Valentina Lodovini, una delle più apprezzate attrici del panorama cinematografico italiano, ci permetterà di assaporare le parole di Atwood nella versione di Gaja Cenciarelli, che introdurrà la lettura raccontando come è entrata nel suo mondo letterario.
Venerdì 2 febbraio tre gli appuntamenti.
Alle ore 17 con Gina Maneri e “Saer, Onetti e gli altri: il traduttore camaleonte”. In traduzione è preferibile un approccio filologico o autoriale? Le cose non sono così semplici: chi traduce deve saper affrontare scritture diverse e modulare il suo approccio, capire quando la forma è sostanza e quando invece la scrittura è solo un veicolo per raccontare delle storie.
Alle 18 tocca a Marco Federici Solari con “Satira e sintassi: tradurre la comicità di Brecht”. La traduzione del comico mostra i cortocircuiti tra le culture: ciò che fa ridere gli uni lascia perplessi gli altri. E si è allora costretti alla riscrittura. Di esempio in esempio, con lo sguardo sempre rivolto ai problemi della resa linguistica, affronteremo un maestro della satira come Bertolt Brecht.
Infine alle 19, “Nobel oblige: tradurre i maestri” con Maurizia Balmelli, Margherita Carbonaro e Anna Ruchat, moderati da Vittoria Martinetto. Le traduttrici che hanno reso in italiano, tra le altre, le opere dei premi Nobel Herta Müller e Thomas Mann (Carbonaro), Jean-Marie Le Clezio (Balmelli), Elfriede Jelinek, Nelly Sachs e Heinrich Böll (Ruchat), stimolate da Vittoria Martinetto (traduttrice e docente di letteratura iberoamericana all’Università degli studi di Torino) raccontano difficoltà e piacere di tradurre opere immortali.
Tre gli incontri anche di sabato 3 febbraio, tutti la mattina.
Si inizia alle 10 con Federica Aceto e “Ali Smith: la lingua inglese come personaggio”. Ali Smith fa un uso originale e personalissimo della lingua inglese, che nei suoi libri trascende il ruolo di semplice veicolo di senso, diventando a tutti gli effetti un elemento fondamentale della storia, un vero e proprio personaggio. Ciò rende particolarmente difficile e stimolante il compito di chi traduce, costantemente sul filo del paradosso e dell’intraducibilità.
Alle 11 è la volta di Fabio Pedone con “Rifare il classico: tradurre il mondo alla rovescia dei Viaggi di Gulliver”. Ritradurre un classico moderno come Gulliver’s Travels non significa riprodurlo con una patina linguistica d’epoca, ma ridargli vita nel momento attuale, con tutti i suoi paradossi, per provare a ricreare un’utopia concreta: l’emozione impregiudicata della prima lettura in un pubblico coevo.
Chiude la rassegna alle 12 Lorenzo Flabbi con “Tradurre Annie Ernaux, le sfide della scrittura esatta”. In traduzione, è più facile riprodurre in maniera convincente le sinuosità di un raffinato arabesco (la scrittura di Julien Gracq, ad esempio) o la traiettoria di una linea precisissima che non ammette deviazioni (Annie Ernaux, per dirne una)? Si elabora qui una possibile risposta, appoggiandosi a una fedeltà traduttiva lunga dieci anni.
Durante i tre giorni si indagano gli aspetti più camaleontici di questo mestiere che richiede solitudine ma suscita contatti inaspettati, costringe all’attenzione ma addestra alla fantasticheria. Partendo da scrittori e scrittrici del calibro di Margaret Atwood, Herta Müller, Thomas Mann, Jean-Marie Le Clezio, Elfriede Jelinek, Heinrich Böll, Annie Ernaux e Bertolt Brecht esploriamo i problemi della resa linguistica grazie a traduttori e traduttrici che ogni giorno affrontano la difficoltà e il piacere di tradurre opere immortali, il filo sottile tra paradosso e intraducibilità, il bisogno di capire quando la forma è sostanza e quando invece la scrittura è solo un veicolo per raccontare delle storie. (aise)

